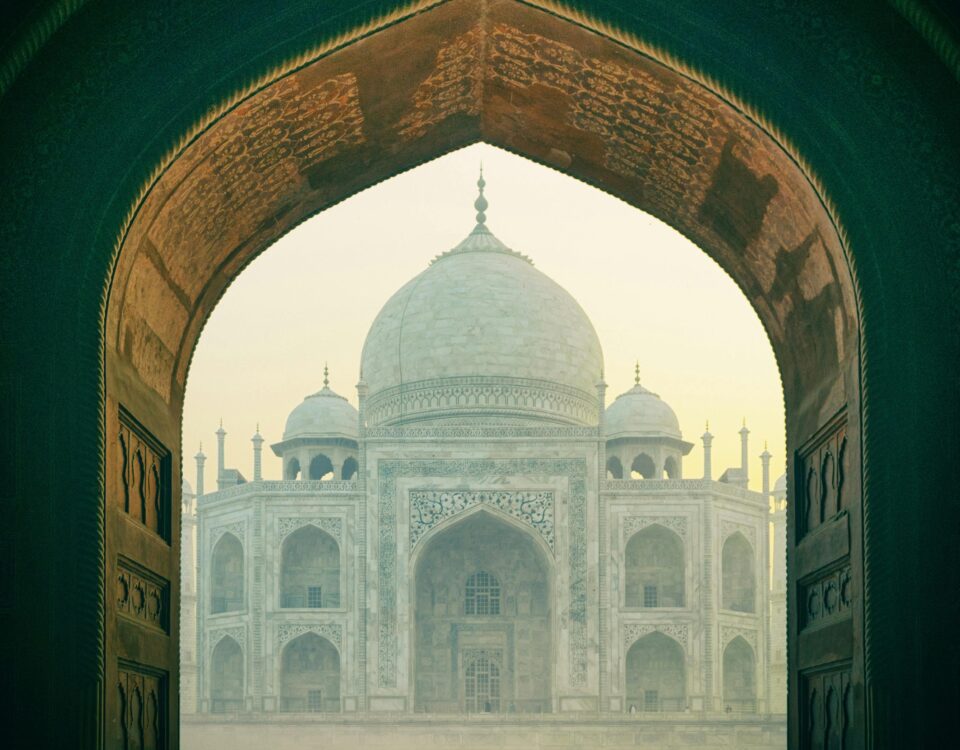Questo articolo ti permetterà di avere ben chiare in testa alcune strategie su come valutare un CAP. In particolare, su come valutare il premio iniziale che paghi per acquistarlo.
“ma che è ‘sto cappe?”
Mi rendo conto che messa così, CAP di per sé significa tutto o niente.
Ma permettimi da fare una piccola premessa.
Se sei un imprenditore potrebbe interessarti parecchio quello che sto per dirti.
Anche se sei un professionista, ovviamente.
Nel primo caso, è possibile infatti che un CAP tu lo abbia sottoscritto realmente, per la tua azienda (Non ti incuriosisce sapere cosa ci sta dentro?)
Nel secondo caso, perché magari è stato proprio il tuo cliente a sottoporti per un contratto CAP una analisi tecnica e giuridica.
“Tommaso, sono postumo delle vacanze estive – ci sto capendo il giusto… spiegati meglio”
Ok, se non hai ben in testa cosa sia un CAP è bene fare un passo indietro.
Sai perché?
Il “CAP” è un “derivato”.
Per essere più specifici, rientra nella famiglia delle “opzioni”.
Permettimi di tranquillizzarti, prima che tu decida di abbandonare definitivamente questo post (non lo fare!).
Non preoccuparti se i termini sembrano complessi o trascendentali.
Ai fini di questo post, ti sarà sufficiente comprendere (e riscontrare direttamente sul tuo caso) …
… il funzionamento del (tuo?) CAP;
… come valutare il CAP.
Se sei capitato per la prima volta su questo blog, ti invito spassionatamente ad iscriverti alla mia NEWSLETTER.
Perché devi iscriverti alla newsletter?
Te la faccio molto breve.
E’ uno strumento integrativo per la tua dieta informativa.
Ricevi una mail con cadenza settimanale – ogni Venerdì mattina:
>> CLICCA QUI PER ISCRIVERTI <<
Nulla più.
Ecco cosa contiene…
… Consigli pratici e diretti sulla gestione di un contenzioso (qualunque ruolo tu rivesta);
… Spunti e strumenti per farlo;
… Impressioni personali tratte da casi reali;
… Collegamenti a guide e-book che ti saranno utili per apprendere aspetti tecnici difficilmente “estraibili” dalla semplice lettura della giurisprudenza.
Tutte cose che non trovi (solo) navigando semplicemente sul blog.
Non ti costerà altro che un po’ di attenzione di lettura (10’ al massimo) ogni settimana:
>> CLICCA QUI PER ISCRIVERTI – FALLO ADESSO! <<
E per di più è semplicissimo.
Ti basta cliccare sui vari > LINK < in grassetto, scrivere il tuo nome e la tua e-mail.
Ti unirai a decine e decine di professionisti, imprenditori e “consumatori” che già fanno parte dei lettori.
Fatto? Molto bene.
Tornando al “CAP”, condividerò ogni elemento utile che ho tratto dalla mia esperienza personale.
Ti guiderò passo passo, per cui… seguimi e non scollarti dallo schermo.
Il mio obiettivo è quello di rendere dannatamente “potabili” alcuni concetti che
… per studiarli
… per applicarli
Richiedono uno studio e un’applicazione costante.
Ti sarà sufficiente prendere in mano uno dei pilastri sui derivati – per me fonte di grande ispirazione – come J. C. Hull, Opzioni, Futures ed Altri Derivati per capire che non sto affatto scherzando.
Ovviamente non tratta solo di CAP, anzi. Se vogliamo, son pure marginali.
Non ti nascondo che per me è stato una delle pietre d’angolo della mia cultura sui derivati, ed in particolare
… sugli “Interest Rate Swap”
… sulla valutazione del Mark To Market.
Proprio da queste sono partito per affinare alcune strategie su come valutare un CAP.
Come avrai capito, con questo post cercherò di condividere tutto quanto da me appreso.
Ma perché dovrei informarti su un qualcosa di cui mai si parla o che è argomento di nicchia ?
Lascia che te lo dica.
I motivi sono molti.
Spesso gli strumenti apparentemente più “nobili” (tra poco capirai perché) e innocui celano vasi di pandora.
Oltre che una dispersione ingiustificata di risorse che mai ti aspetteresti.
“continuo a non comprendere”
Ok, salto un attimo di palo in frasca…
Hai presente cosa accade, per esempio, nei piani di ammortamento alla francese finalizzati al rimborso di un mutuo?
Che dire invece dei piani finanziari di un leasing?
A leggere e guardare i contratti, tutto può sembrare regolare e a “posto”, giusto?
Ed invece può essere dimostrato che non è così.
Se non sai di cosa parlo, ti consiglio di leggere (dopo aver concluso questo post) questi articoli a titolo di esempio:
- Ammortamento alla francese: perché è importante fare la perizia
- Leasing: Come calcolare il tasso interno di attualizzazione (e perché è importante.
Giusto per non far confondere la tua preziosissima attenzione (ti ringrazio per avermela concessa fino a qui), questi articoli nulla c’entrano con questo post.
… ma ne hanno un elemento in comune, ovvero …
La capacità di saper dimostrare che molte volte l’apparenza inganna. A tal punto da poter far mettere in discussione le tue scelte.
Pensaci un attimo.
Avresti mai sottoscritto un mutuo sapendo che nascondeva “interessi” non giustificati?
Come ti senteresti se ti dico che il tuo finanziamento è stato regolato ad un tasso d’interesse più alto di quello che tu (credevi) di aver sottoscritto?
Devo dirti la verità.
Nella mia esperienza ultradecennale, ho ben compreso che in uno strumento “bancario” e “finanziario”, ogni elemento, ogni costo, ogni pretesa non deve mai essere data per scontata.
Tanto più se lo strumento si fa sempre più complesso.
I derivati finanziari lo sono.
Ti ho già dato alcuni spunti (spero utili) in tema di IRS.
Adesso è il turno del “CAP”.
Se sei lettore della mia NEWSLETTER, ne avrai già avuto una bella infarinatura in qualche e-mail settimanale.
“Perché il CAP?”
Entriamo nel “vivo” del post.
Da questo aneddoto capirai senz’altro tutti i motivi che mi hanno spinto a trattarlo. Ne trarrai senz’altro un gran valore.
Qualche settimana fa ho avuto modo di trattenermi con uno stimatissimo collega.
Sarei “CTP” del fallimento di cui è curatore in alcune controversie (sono sempre grato nella fiducia dimostrata dai colleghi!)
Per un “classico” commercialista Maggio-Luglio è sinonimo di “chiusura di bilanci” e “dichiarazioni dei redditi” (lo è anche per il nostro studio, naturalmente).
Ironia della sorte, proprio in fase di chiusura di bilancio di alcune aziende “strutturate”, il collega non ha potuto far a meno di notare dei “proventi” insoliti. Insoliti per aziende “non financial”.
Non si tratta ovviamente di proventi “caratteristici”.
No, ti parlo di proventi legati ai “differenziali” ricevuti in esecuzione di un derivato “CAP”.
CAP stipulati soprattutto nei periodi “COVID” e post-”COVID” quando l’impennata dei tassi non era uno scenario così probabile e realista.
Lascia che te lo dica.
Apparentemente, tutti questi “CAP” potrebbero sembrarti abbondantemente vantaggiosi – e lo sono, adesso, non lo metto in dubbio.
A mio modesto avviso, però, limitare il giudizio su questo “lato” ti fa perdere focus sull’altro… il “quanto” è stato pagato quel “CAP”.
La maggior parte di noi si concentra sul beneficio presente (proventi finanziari legati all’aumento dei tassi di interesse – a prima vista interessante, vero?).
Ma la verità è che molto spesso il “CAP” non viene mai analizzato per l’intero.
Raccontiamoci tutte le favole che vogliamo, ma gira che ti rigira il CAP è sempre stato visto (anche da me, lo ammetto) come una specie di assicurazione…
… Paghi il premio per assicurarti che il tasso variabile dello strumento sottostante non sia superiore ad un limite prestabilito (il CAP, appunto…).
Il fine è certamente “nobilissimo” (pensa ai vantaggi per le aziende che ti ho citato sopra in termini di risparmio di interessi).
Tuttavia …
… ti sei mai concentrato sul “premio” pagato dal cliente per avere quel “CAP?
… ti sei mai chiesto come viene di fatto quantificato questo premio “benedetto”?
Con questo post mi prefiggo di darti una risposta.
E allora…
A COSA SERVE IL CAP?
Il fine che mi sono preposto con questo blog (ma soprattutto con la correlata “newsletter”) è quello di
… semplificarti il più possibile concetti tecnici che altrimenti ti richiederebbero una “saccata” di ore di studio e di applicazione (lo hai tutto questo tempo?)
… offrirti le “lenti” giuste. Sì, per mettere a fuoco alcuni aspetti della tua vita imprenditoriale e professionale.
Io stesso – di concerto con l’attività di “blogger” e “commercialista” – gestisco uno studio professionale.
Tra le attività principali, la cura (quotidiana) di rapporti bancari e finanziari è all’ordine del giorno.
Senza di questa (cura), potremmo chiudere il bandone domani mattina!
Ma bando alle ciance.
“a che serve il cap?”
La finalità principale è quella di fornire protezione contro la possibilità che i tassi d’interesse superino un certo “livello” – il “cap rate” (o tasso “cap”).
Nella forma più comune di “CAP”
… l’investitore versa un “premio” iniziale per assicurarselo.
… la banca corrisponderà un pagamento nei suoi confronti solo e soltanto se il valore del tasso d’interesse sottostante è superiore al CAP.
… la differenza tra tasso d’interesse e tasso “CAP” viene calcolata sul capitale nozionale di riferimento (per il periodo di tempo predefinito).
Ti faccio un esempio.
Supponiamo che:
- il nozionale del derivato sia di Euro 1.000.000;
- il nozionale sia correlato ad un contratto di mutuo (l’operazione da “coprire”) indicizzato all’Euribor 6 mesi;
- la vita del CAP sia 5 anni;
- il CAP sia fissato al 4%.
Il CAP protegge, in questo caso, dalla possibilità che il tasso d’interesse del mutuo sottostante superi il 4% (oltre naturalmente lo “spread”).
Ad ogni data di revisione si osserva la quotazione dell’Euribor 6m.
Se
- L’Euribor 6m (ad. Es. 3%) è inferiore al CAP (4%) – il “payoff” per l’investitore è nullo;
- L’Euribor 6m (ad. Es. 5%) è superiore al CAP (4%) – il “payoff” per l’investitore è quantificabile nell’1%.
Solo in questo secondo caso, il “CAP” offre un pagamento in favore della mutuataria per la differenza tra Euribor e “cap” (pari all’1%), calcolata sul nozionale di riferimento. La copertura ha effetto.
Fin qui tutto chiaro?
Molto bene, andiamo oltre.
COME VALUTARE UN CAP?
In uno specifico articolo ti ho parlato di come poter “prezzare” un IRS. Naturalmente offrendoti uno solo dei metodi tecnicamente possibili.
Perché sì, la valutazione del “mark to market” di un interest rate swap può scontare più metodologie di calcolo.
Il buon Hull, ad esempio, ne rappresenta parecchie, nel suo volume.
Prima di tutto, devi quindi assicurarti di una cosa.
Devi accertarti che
… il contratto “quadro” – in parole povere, il documento che riporta le clausole generali di investimento tra te (o il tuo cliente) e la banca
… la scheda prodotto – in soldoni, il documento (accettato per iscritto, mi raccomando) che riporta gli elementi numerici ed i dati del derivato
Riportino (almeno uno dei due) l’esatta formula matematica per valutare e misurare
… il mark to market, appunto;
… gli scenari probabilistici;
… i costi ed i compensi percepiti dalla banca.
Quando ho a che fare con un “CAP”, pongo molta attenzione sul primo e sul terzo punto.
Come ti ho detto prima, infatti, quando investi in un CAP “cacci fuori” i soldi, subito. Paghi un “premio” per assicurarti che il tasso variabile sottostante non superi mai un certo livello.
Ricordi?
La “scheda prodotto” deve dirti come si compone quel “premio”.
Di solito si stratifica in
… costi di intermediazione sostenuti dalla banca;
… il margine apposto della banca (altrimenti detto “mark up”);
… il valore di mercato (il nostro mark to market);
Il mark to market lo paghi, naturalmente, per rendere “nullo” il valore iniziale del CAP.
Il fine (apparentemente) nobile è quello di assicurarti il “blocco” del tasso di interesse, ricordi?
Al di sopra del livello prefissato non può andare.
Ed è giusto che tu paghi – per entrare nella copertura.
Ma deve anche essere giusto quel che tu paghi.
Ed eccoci al bandolo della matassa.
Abbiamo detto che il CAP(pello) fissa un tetto al tasso di interesse variabile (lo so, è doveroso ripeterlo).
Come viene misurato questo tetto?
Una cosa è certa, non a caso.
Ci dev’essere una valutazione a priori dei tassi d’interessi attesi …
… ed è qui che vorrei che ti concentrassi.
L’impostazione che vorrei condividere con te è la medesima che ti avevo prospettato per un “classico” interest rate swap.
Ecco come mi comporto quando mi viene sottoposto un “CAP”.
Passo n. 1
Prima di tutto, mi accerto se esiste una formula (matematica) tra le condizioni scritte – proprio come ti ho anticipato sopra.
Passo n. 2
In secondo luogo determino la “zero swap curve” – la curva dei tassi attesi ad ogni scadenza prevista dalla “scheda prodotto”.
Non voglio dilungare la scrittura ulteriormente. In questo POST (cliccaci sopra) ti ho già illustrato come fare.
Hai fatto mente locale?
Bene, prosegui.
Il CAP fissato dalla banca si troverà senza dubbio in un range compreso tra
… il valore medio – quello che renderebbe nulli tutti i differenziali (in un “IRS”, altrimenti detto tasso “swap”); e
… il valore atteso più elevato riscontrato.
Ciò ha senso, perché altrimenti non esisterebbe ragione al mondo per costruire il “CAP”.
Il tuo vantaggio futuro (o, certo, del tuo cliente) esiste solo ad una condizione.
Che la tendenza del tasso d’interesse atteso sia superiore al CAP.
In questo modo
… paghi l’interesse variabile sottostante per mezzo del contratto di credito “collegato”;
… ricevi la differenza tra il tasso variabile (maggiore del CAP) ed il CAP, dalla banca, per mezzo del contratto chiaro.
Passi successivi
Dopodiché, vado dritto per questa strada:
- prendo i tassi forward (attesi) alla data di ogni scadenza prevista durante la vita del cap;
- verifico quando (e se) sono superiori al CAP prefissato nella “scheda prodotto”;
- attualizzo SOLO i differenziali “positivi” (tasso forward – cap > 0) eventualmente rilevati col tasso “spot” (a pronti) di riferimento;
- considero “zero” i differenziali “negativi” (tasso forward – cap < 0) – per natura stessa del CAP, questi non comportano esborsi per l’investitore;
- eseguo la sommatoria dei differenziali positivi attualizzati.
“concettualmente chiaro, ma illuminami sulla formula che dovrei utilizzare”
La formula che utilizzo non è altro che quella che solitamente impiego per valutare il mark to market di un IRS – riportata nel dettaglio in questo POST linkato (cliccaci sopra).
Nel caso del CAP, la riadatto semplicemente in questo modo:
Dove:
- vt rappresenta il tasso d’interesse forward, stimato ad ogni scadenza t;
- cap rappresenta il valore del CAP concordato ;
- n è il numero delle scadenze contrattualmente stabilite;
- N è il valore del nozionale di riferimento;
- st è il tasso swap stimato per ogni scadenza t sulla base della swap zero curve
Ecco fatto.
Ho il mio mark to market. O meglio, la componente imputabile al Mark to Market compresa nel premio sborsato all’inizio.
MAGGIORE O MINORE ?
Questo è il “Test”.
Se la componente “mark to market” è maggiore di quella effettivamente pagata…
… “Houston, abbiamo un problema” (cit. Jack Swigert)
Abbiamo un problema di “sovrastima” del premio.
Il nostro premio è ingiustificatamente più alto.
Il cliente ha pagato di più di quello che doveva
Se così è …
COME AGIRE?
Puoi pensare di andarlo a recuperare con una azione specifica.
Tutto qui?
No di certo.
Come accade molto spesso quando si tratta di contenzioso bancario, è molto più semplice – per quanto mi riguarda – prospettare un’azione di recupero, rispetto a “impalcarla”.
In particolare la strada che mi prefiggo di perseguire è quella volta al recupero del premio maggiorato indebitamente versato.
Ma non prima di aver redatto una perizia tecnica ad hoc. Trattandosi di dimostrazioni maledettamente tecniche, non puoi non passare da un calcolo matematico circostanziato (vedi sopra).
L’azione di mero recupero non è certamente l’unica.
Ricordi tutto quello che siamo detti riguardo alla necessaria indicazione della formula tecnica del mark to market?
Pensaci bene.
Se effettivamente non è riportata da nessuna parte, puoi far leva (anche) sul principio di diritto espresso dalla ormai nota sentenza 8770/2020 (Cassazione a Sezioni Unite).
In questo caso, non solo c’è un problema di sovrastima ingiustificata, bensì di
nullità (integrale) del CAP. Manca, in effetti, l’espressione numerica dell’oggetto del contratto.
Come hai potuto constatare, infatti, la componente “Mark To Market” è essenziale anche per un contratto CAP – così come per l’IRS.
Adottando più formule di calcolo, naturalmente la valutazione iniziale del CAP cambia.
“Sovrastima” e “Nullità” potrebbero rappresentare una “combo” interessante per supportare l’azione di recupero.
!! MA ATTENZIONE!!
Non è comunque uno scherzo.
I rischi in gioco sono più alti rispetto alla “media”.
Rischio n. 1 – Giudizio Ordinario o Arbitrato?
Anzitutto, valuta sempre il foro competente e la presenza di eventuali clausole di risoluzione delle controversie.
Spesso puoi trovarti di fronte clausole “arbitrali” – e gli arbitrati costano.
Il costo potenziale potrebbe non giustificare il procedimento.
Se tu o il tuo cliente non siete abbastanza certi del successo, consiglio di lasciar perdere…
Il gioco deve comunque valere la “candela” – per il cliente.
Rischio n. 2 – Scarsità di precedenti
Inutile nascondersi dietro un dito.
Fino ad oggi, il “grosso” dei contenziosi sui derivati trattavano “IRS”.
La componente “giuridica” della faccenda (mi riferisco ovviamente alla sentenze pubblicate nel tempo) si è formata principalmente sugli IRS.
La maggioranza dei principi elaborati dalla giurisprudenza (tra cui la Cassazione, Sezioni Unite, 8770/2020) sono elaborati partendo (almeno per quanto ne so io) proprio dagli IRS.
C’è dunque un grosso rischio.
Che un Tribunale – oltre che ovviamente la difesa della banca – possa non apprezzare i tuoi (o dei tuoi consulenti) sforzi solo perché tutto quanto detto per gli IRS non vale per i CAP.
Per quanto non possa condividere una impostazione (per me) tanto ceca, bisogna essere pratici…
… rigetto e (pesante) condanna alle spese non sono scenari remoti.
La sensibilità professionale sarà l’ago che fa propendere la bilancia da un lato (azione sì) piuttosto che dall’altro (azione no).
Per quel che può valere, lascia che ti dica come la penso.
Nessun contenzioso è immune da rischi – questo lo sappiamo.
Come già ho avuto modo di descriverti in altri post, considero di estremo valore l’attività istruttoria.
La parte che mi compete si concretizza nella perizia tecnica – che va oltre le pre analisi di rito e le ricostruzioni.
Nella perizia devi semplicemente scrivere.
… solo scrivendo ti rendi conto se tutto quanto sostieni e dimostri è giustificabile senza dover inventare nulla.
… solo se la scrittura, accompagnata da numeri, tabelle e prospetti, scorre come un flusso puoi ritenerti nel giusto
In altre parole, solo se ti trovi nello stato psicologico (e magico) di “flow” (secondo la concezione dello psicologo “Mihály Csíkszentmihályi”), le basi tecniche sono solide.
Quando trovo in perfetta armonia:
- numeri e formule;
- stato mentale di flow;
- scrittura che scorre da sola.
In cuor mio son tranquillo a (far) correre il rischio.
Questa unione costituisce l’ “ago della bilancia” che per me fa la differenza.
L’ultima decisione, ovviamente, spetta a te (se rappresenti il cliente) o al cliente stesso.
p.s.
Se ti è piaciuto, puoi farmelo notare in due modi.
Condividilo con amici o colleghi come vedi in calce alla seguente pagina.
Lascia i tuoi dati iscrivendoti alla NEWSLETTER così come decine e decine di imprenditori, consumatori e professionisti prima di te.
Fallo subito cliccando su questo link