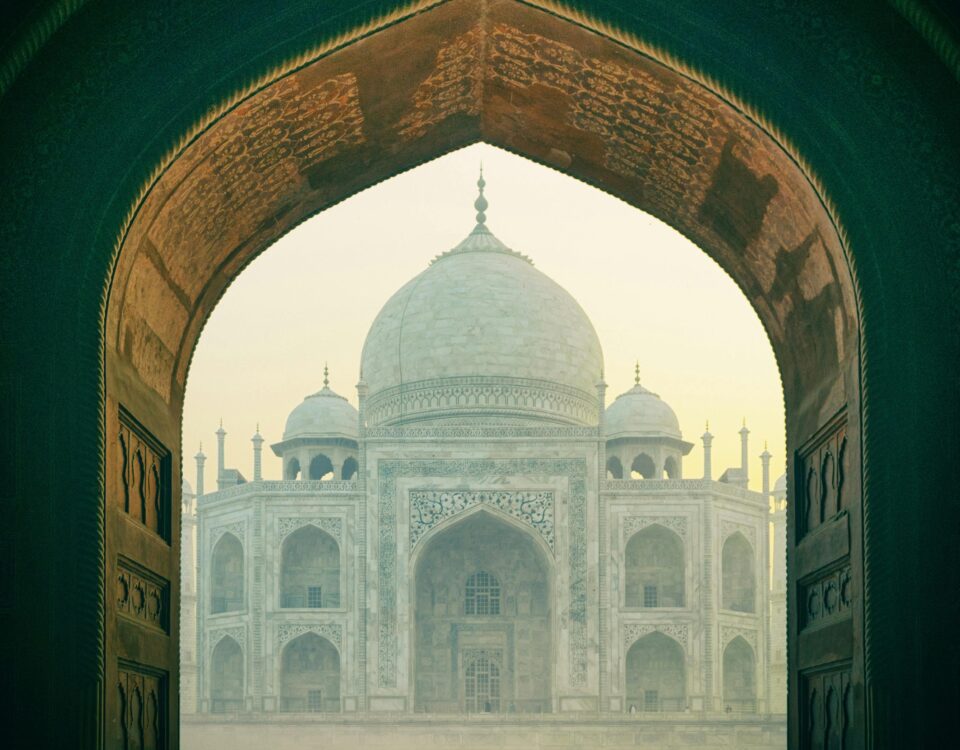Nel momento in cui credi di aver compreso che la concessione abusiva del credito esiste, è giunto il momento di spiegarti come puoi quantificare il danno cagionato.
Prima di cominciare, però, ti suggerisco di compilare il modulo della NEWSLETTER periodica cliccando sul presente LINK. E’ facilissimo iscriversi, ancor più semplice cancellarsi.
Ti sei iscritto? Ti ringrazio, adesso possiamo proseguire.
Ricordi cosa ti avevo raccontato nel precedente post in merito come capire se sussiste abusiva concessione del credito?
Se la tua memoria è corta, lascia che te la rinfreschi per un attimo.
Immaginati questo scenario.
Sei un curatore fallimentare (adesso liquidatore giudiziale).
Hai compiuto diligentemente le tue indagini che ti hanno consentito di estrapolare elementi utili per desumere che:
- l’azienda fallita era già insolvente da almeno 3 anni;
- il mantenimento delle (o la concessione di nuove) linee di credito ha permesso all’azienda insolvente di stare sul mercato durante questo tempo.
Senti puzza di bruciato?
Beh, l’odore è forte…
Ma prima di attivare un contenzioso vuoi esser in grado di quantificare il danno da (presunta) abusiva concessione di credito.
In questa fase, la preoccupazione si trova a livelli dannatamente alti. Sai infatti che:
- nel caso tu avessi ragione, devi essere convincente. Per agire, sai che devi chiedere (e farti dare) l’autorizzazione al Tribunale;
- devi esser certo che “numeri” rendano conveniente – per i creditori – l’azione;
- nel caso di soccombenza, le spese che andrai a sostenere – in qualità di “amministratore” del patrimonio della fallita – saranno salate.
Ecco che allora diventa importante avere un metodo preciso per quantificare il danno da abusiva concessione del credito.
Ed è qui il problema più delicato.
In un altro post ti ho dato alcuni consigli su come poter quantificare il danno per illegittima segnalazione in centrale rischi.
Se non l’hai letto, non perder tempo e clicca sul link sopra. Senza, però, abbandonare questa pagina.
Starai pensando che cosa possa incastrarci con l’abusiva concessione del credito, giusto?
Lascia allora che ti dica una cosa.
Le due fattispecie – abusiva concessione del credito ed illegittima segnalazione in centrale rischi – hanno alcune connessioni interessanti, a mio umile avviso.
Ti fornisco alcuni elementi che traggo direttamente dalla mia esperienza ultra decennale (so che la mia età potrebbe tradirmi, ma ti assicuro che è così!).
Non stai nella pelle per conoscerli?
Continua a leggere.
Elemento n. 1
In entrambi i casi devi sempre concentrarti su due passaggi consecutivi:
- capire se c’è il danno (o quanto meno se sia “più probabile che non” ipotizzabile);
- quantificare il danno.
Tra i due è senz’altro più facile accertare il primo elemento.
Stai attento però.
Non ti sto dicendo che è “facile” capire se c’è il danno.
Non prendiamoci in giro.
Capire se c’è il danno richiede notevoli sforzi analitici, sia che si tratti di abusiva concessione del credito sia che si tratti di illegittima segnalazione in centrale dei rischi.
Direi anzi che è dannatamente complicato.
Con i giusti passaggi, però, tu sarai in grado di estrapolare degli elementi oggettivi che ti consentiranno di poter prender atto dell’esistenza del danno.
Ti starai domandando perché ti ho detto è “più facile” quando in realtà il processo è complesso, ho indovinato?
In effetti può sembrare un controsenso.
Ma la giusta chiave di lettura è quella che segue.
E’ la quantificazione del danno (punto “due” dell’elenco) ad essere una prova maledettamente diabolica.
Se devo dire la verità, è un vero e proprio atto di coraggio.
Elemento n. 2
Sono appassionato di contenzioso bancario da ben oltre dieci anni, come avrai capito leggendo i vari post di questo blog.
Per quanto mi possa sentire un “principiante” (nel senso che la voglia di accrescimento delle conoscenza non si ferma mai) mi sono reso conto di un fatto.
Quando tratti il danno da abusiva concessione del credito e da illegittima segnalazione in centrale rischi devi vestire i panni di un “Disc Jockey”.
Non è uno scherzo, per cui lasciami spiegare.
Intendo dire, infatti, che per quantificare il danno devi attingere e “mixare” competenze e nozioni da più branchie e materie diverse. Soprattutto da quelle aziendalistiche, che apparentemente nulla hanno in comune con il diritto bancario.
Nel caso di danno da abusiva concessione del credito i tuoi “vinili” da re-mixare sono:
- il diritto bancario (beh, non si può mai prescindere da questo);
- il diritto fallimentare e di crisi aziendale;
- analisi di bilancio e valutazione aziendale.
Se stai sgranando gli occhi, spalancando la bocca e sudando freddo, probabilmente la lettura di questo post è terminata per te. Spero che ti sia comunque piaciuta e che navigherai sul BLOG con una certa ricorrenza.
E non dimenticarti di iscriverti alla newsletter per usufruire di ulteriori contenuti di valore a cui non puoi attingere solo accedendo al sito.
Se invece stai palpitando dall’interesse – come me! – e dall’emozione di sapere qualche dritta (spero) utile, persevera e continua a leggere.
Sei pronto?
Bene, perché non vedo l’ora che tu legga (e rilegga) i miei consigli che ti elenco in seguito.
Naturalmente, non sono di mia invenzione.
Divulgo quanto apprendo dalla mia esperienza professionale nonché da quanto estrapolo dalla più attenta giurisprudenza in merito.
Ma adesso ci siamo.
CONSIGLI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO
I consigli che ti fornisco non hanno molto senso – in termini prettamente giuridici – se non gli accosti ai principi che si stanno consolidando in giurisprudenza.
Nel precedente POST ti ho rammentato la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1387/2023.
I piani su cui si sofferma sono essenzialmente quello ECONOMICO e quello CONTABILE.
Quali sono le differenze?
Beh, per quanto mi riguarda, si tratta di due facce della stessa medaglia.
Il danno sul fronte economico esprime, infatti, la diminuita consistenza del patrimonio.
Il danno sul piano contabile, invece, riflette l’aggravamento di perdite favorite dalla continuazione dell’attività di impresa.
Potremmo intenderle una come sottoinsieme dell’altra.
Sono, infatti, dalla tua parte se istintivamente pensi che senza l’aggravamento di perdite d’esercizio non ci sarebbe erosione del patrimonio.
Il mio consiglio, pertanto, è quello di evidenziare entrambi gli aspetti.
LA DIMINUITA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO
Tra i due “piani” è quello che preferisco di più.
Medito sempre su chi è il soggetto principalmente danneggiato da una abusiva concessione del credito.
La risposta è abbastanza “ovvia”: la “massa” dei creditori.
Inutile girarci intorno. La loro “garanzia” principale, nel momento in cui instaurano un rapporto commerciale o finanziario con l’azienda (insolvente) non può essere che il patrimonio aziendale.
Nel momento in cui l’azienda opera in perdita perché ha perso i requisiti di marginalità per star bene nel mercato in cui opera, il patrimonio netto viene vanificato.
Nella maggior parte dei casi completamente eroso.
L’azione che il curatore è legittimato a coltivare serve principalmente a ricostituire il patrimonio aziendale eroso dalla abusiva concessione del credito.
Sei sei il curatore, per l’appunto, fai sempre fede al fatto che il tuo obiettivo – anzi la tua missione – è quella di dar maggior soddisfazione possibile ai creditori. Nel rispetto della par condicio creditorum.
“Ma allora, di quale patrimonio si tratta?”
Adesso ci arriviamo.
Solitamente procedo in questo modo.
Non sto a raccontarti nuovamente l’iter di analisi per evidenziare i profili di sussistenza dell’abusiva concessione del credito.
L’importante è capire da QUANDO la banca ha potuto cogliere elementi di insolvenza nel momento in cui:
- ha deciso di mantenere le linee di credito già in essere;
- ha concesso nuovi finanziamenti.
“Si certo, tutti sanno ragionare ex-post, a fatti già accaduti. Messa così sembra che se l’azienda fallisce è colpa della banca che non ha revocato i fidi o ne ha addirittura concessi di nuovi.”
Probabilmente ti stanno balenando in testa frasi di questo tipo.
Non fraintendermi.
Non ti sto dicendo che se l’azienda (poi fallita) godeva di linee di credito, il danno per i creditori è stato generato dal proseguimento dell’attività “grazie” agli affidamenti mantenuti.
Il ritardo della dichiarazione del fallimento non è per forza imputabile agli istituti di credito che hanno mantenuto gli affidamenti in essere.
L’abusiva concessione del credito rappresenta un caso limite che deve essere meticolosamente dimostrata.
Ed è davvero complesso farlo.
Per questo ho deciso di condividere quello che ho potuto apprendere dalla mia esperienza “sul campo”.
Il valore che ne puoi trarre è potenzialmente altissimo!
Ma non voglio dilungarmi troppo, per cui torniamo a noi.
Ti ho accennato al Patrimonio aziendale vanificato…
Ma, in fondo, di quale patrimonio si tratta ?
Ecco il mio consiglio.
Annota preliminarmente i seguenti valori
- il Patrimonio Netto alla data della dichiarazione del fallimento – chiamalo per semplicità “PN1”;
- il Patrimonio Netto indicato nel bilancio da cui hai dimostrato l’insolvenza dell’impresa – chiamalo per semplicità “PN2”.
Arrivato a questo punto, il pregiudizio patrimoniale per la massa dei creditori non è altro che la differenza data da:
PN1 – PN2
Operando questa differenza risponderai alla domanda:
“a quanto ammonta la diminuzione di patrimonio netto dal bilancio manifestante indici oggettivi di insolvenza a quello del fallimento/liquidazione giudiziale?”
Il PN1 lo determinerai in modo tutto sommato semplice. Ti basterà ricostruire lo Stato Patrimoniale alla data della sentenza.
Il PN2 è più complesso trovarlo.
Non ti allarmare troppo.
Puoi utilizzare la seguente strategia.
Seguendo le istruzioni del precedente POST hai capito quando è possibile (quantomeno “ragionevolmente”) apprendere lo stato di “impotenza” finanziaria non transitoria dell’azienda.
Ricordati che se tu hai potuto apprendere questo “stato”, la banca è stata certamente in grado di capirlo molto più velocemente (e ben prima) di te.
Io prendo in considerazione il PN2 dell’esercizio in cui:
- ho appurato tutti gli indici di insolvenza;
- ho appurato che tali indici sono frutto di un peggioramento costante rilevato nei 2 o 3 esercizi precedenti;
- a fronte di tali indici, l’anno si è concluso con una perdita netta consistente (difficile stabilire un limite preciso. Dipende da caso a caso. Diciamo almeno un terzo);
- a fronte di tale scenario, la banca (o le banche) non hanno ristretto le linee di credito e/o ne hanno concesse di nuove.
Solitamente, controllo anche che in tale contesto non siano stati posti in essere piano di risanamento o procedure preventive volte a gestire e scongiurare la crisi.
In questo caso, le dinamiche dell’intera vicenda cambiano completamente. Ma non voglio dilungarmi troppo in questioni che nulla c’entrano con questo articolo.
Dall’esercizio in cui hai constatato tutto quanto ti ho descritto nell’elenco, l’azienda avrà probabilmente proseguito l’attività conseguendo ulteriori perdite.
A danno, primi fra tutti, dei creditori.
Salvo che non siano intercorsi piani di risanamento, è da quel momento in poi che potevano sussistere i presupposti per far portare i “libri in tribunale”.
Questo è ciò che significa per me la DIMINUITA CONSISTENZA DEL PATRMIONIO.
Ad ogni modo…
Nota Bene (1)!
Quello di sopra può sembrarti un semplice calcolo.
Da un punto di vista algebrico lo è, ma stai molto attento!
I dati che ricavi sono oggettivi. Si tratta di numeri.
Sta alla tua sensibilità professionale stabilire se effettivamente può avere una logica incardinare un’azione di risarcimento del danno di tale portata.
La differenza PN1 – PN2 può assumere valori anche milionari.
Sai che significa?
Che i costi da sostenere per la procedura possono essere molto “salati”, soprattutto in caso di soccombenza.
Meditaci sopra, ogni volta, in maniera stra-approfondita e non lasciarti prendere dall’entusiasmo iniziale né dalla fretta.
Nota bene (2)!
Nel momento in cui scegli l’esercizio in cui prendi in riferimento il PN1, dovresti considerare anche la tendenza degli anni precedenti.
Se in questo esercizio si concretizza l’insolvenza – rilevata con dati oggettivi – è molto probabile che in quelli precedenti (almeno 2 o 3) verifichi un degradamento dei valori tratti da:
- margine di tesoreria;
- indice di liquidità;
- oneri finanziari / fatturato;
- indebitamento/patrimonio netto.
Te ne ho parlato nel precedente post. Per rinfrescarti la memoria, clicca QUI.
Prendine atto. Sono l’anticamera della successiva incapienza – non transitoria – finanziaria.
Se a fronte del degradamento osservato rinvieni:
- la mancata revoca di linee di credito in essere; e/o
- la concessione di “nuove” linee di credito.
Sei sulla buona strada. Quanto meno per sostenere che l’azienda ha proseguito l’attività “gravosa” – a danno dei creditori – grazie alla “droga di liquidità”.
Naturalmente, non considero i casi in cui l’insolvenza è provocata da fattori eccezionali o straordinari che sconvolgono l’equilibrio aziendale dall’oggi al domani.
L’AGGRAVAMENTO DI PERDITE
La diminuzione del patrimonio che ti ho raccontato sopra è il riflesso delle perdite cumulate nel periodo successivo a quello in cui è maturata l’insolvenza.
Per determinare l’ammontare delle perdite subite, non ti resta che sommare i risultati di esercizio successivi a quello in cui hai preso come riferimento il PN1.
“vabbè, ma allora la differenza PN2 – PN1 è più semplice…mi fornisce lo stesso numero, visto che le perdite cumulate decurtano il Patrimonio Netto”
Se pensi questo sappi che hai ragione nel solo momento in cui i soci non hanno, nel frattempo:
- ripianato le perdite con versamenti in conto capitale;
- rinunciato a finanziamenti;
- aumentato il capitale.
Se non riscontri nulla di tutto ciò, il valore delle perdite cumulate potrebbe coincidere.
Altrimenti, no.
In questo ultimo caso, le perdite cumulate ti danno la sensazione del danno creato dalla prosecuzione dell’azienda in perdita.
DIMINUITA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO vs AGGRAVAMENTO DI PERDITE
A questo punto potresti essere in stato confusionale…
Meglio esprimere la diminuita consistenza del danno patrimoniale…o l’aggravamento delle perdite?
Lascia che te lo dica.
A me piace essere prudente.
Preferisco riportare entrambi i valori ma in quest’ottica.
Abbiamo detto che la principale garanzia per i creditori è il patrimonio sociale.
Su questo dovremmo essere d’accordo.
A mio modesto avviso, pertanto, la diminuita consistenza del patrimonio rappresenta il valore portante con cui rappresentare il danno per “abusiva concessione del credito”.
Pur se è annacquato da eventuali versamenti conto capitale effettuati dai soci nel periodo precedente alla dichiarazione di insolvenza.
Tutto qui?
Niente affatto.
Questo dato è solo il piatto principale. Mi piace condirlo con alcuni valori di contorno.
Ecco perché tengo presente (anche):
- il valore delle perdite cumulate che ti ho descritto sopra; nonché
- l’ammontare degli oneri finanziari che hanno gravato il conto economico negli esercizi supportati dalla “abusiva concessione del credito”.
In questo modo, il quadro è senz’altro più colorato ed esaustivo.
CONCLUSIONI
Siamo giunti alle fasi finali.
Credo di averti raccontato molti elementi di valore e di cui non puoi farne a meno quando tratti la delicatissima questione dell’abusiva concessione del credito.
Leggendo il post, hai potuto apprendere:
- la difficoltà nel capire quando hai a che fare con la concessione abusiva del credito;
- la (ancor più) difficoltà nel quantificare il danno eventualmente riconducubile;
- gli elementi numerici essenziali per quantificare il danno da abusiva concessione del credito, sotto molteplici aspetti.
Tali elementi puoi estrapolarli dalla principale giurisprudenza (ti ho citato la recente Cass. Civ. 1387/2023).
Non ho fatto altro che tradurli numericamente!
Vorrei comunque sapere cosa ne pensi. Per cui non esitare a compilare il form in calce alla pagina ed inviare la tua richiesta.
A questo punto, non mi resta che ringraziarti della tua attenzione.
Se hai interesse a ricevere e-mail su ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, non ti resta che compilare il modulo della NEWSLETTER periodica cliccando sul presente LINK. E’ facilissimo iscriversi, ancor più semplice cancellarsi.
Alla prossima.
Tommaso